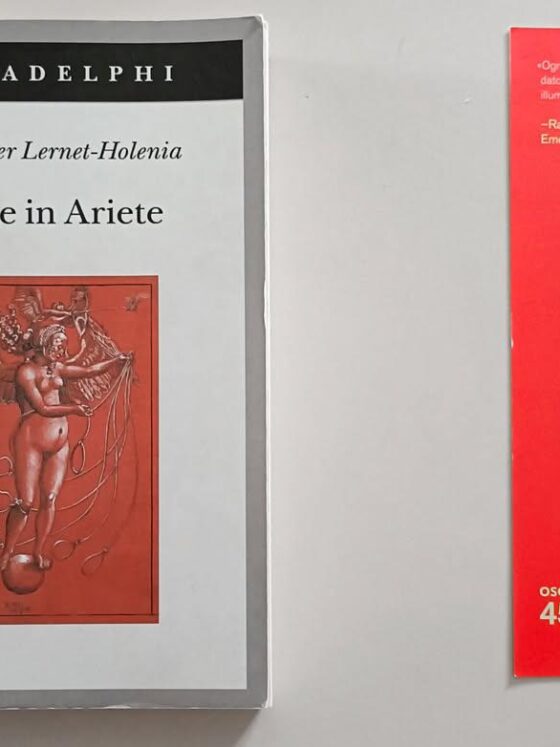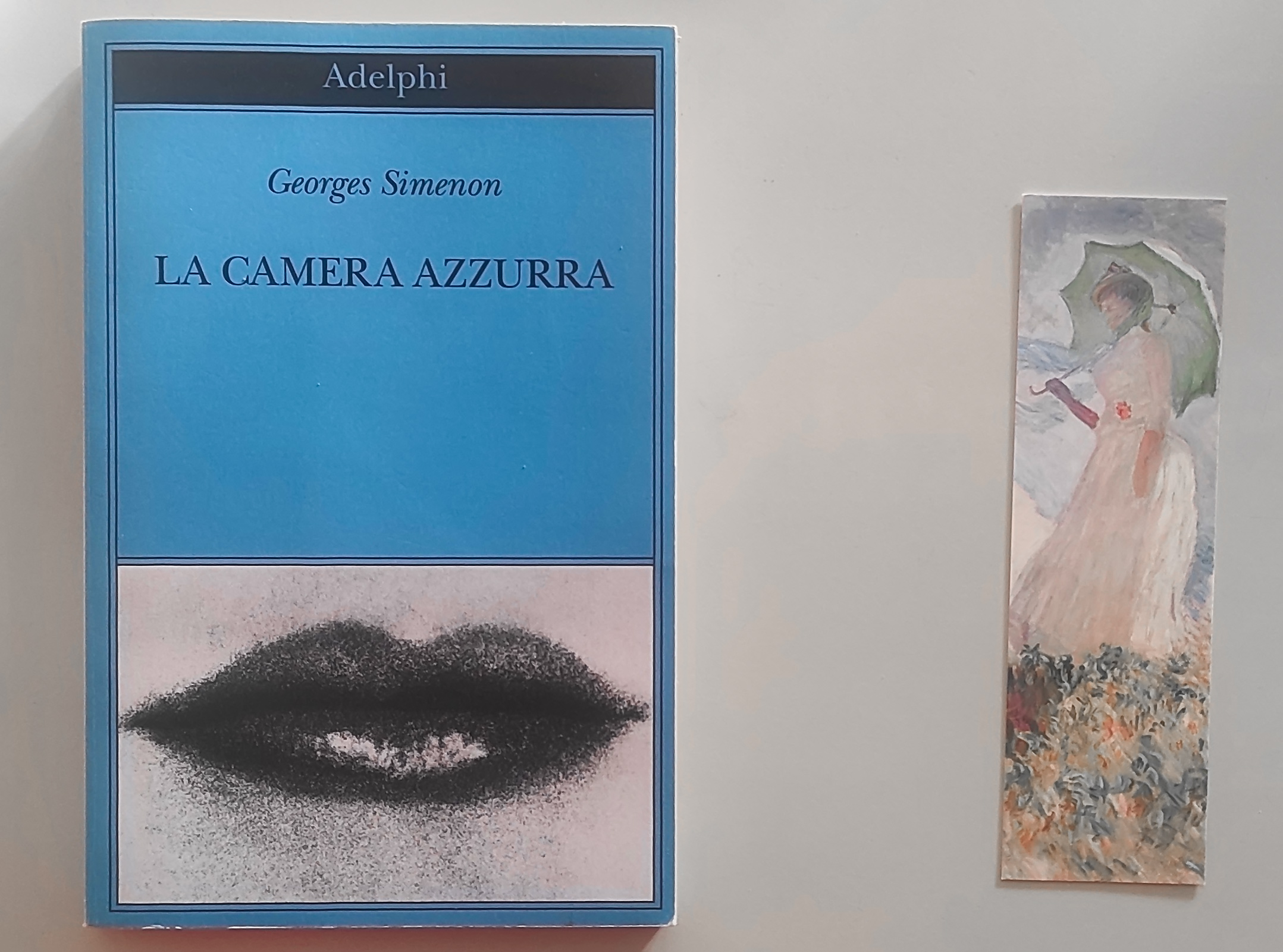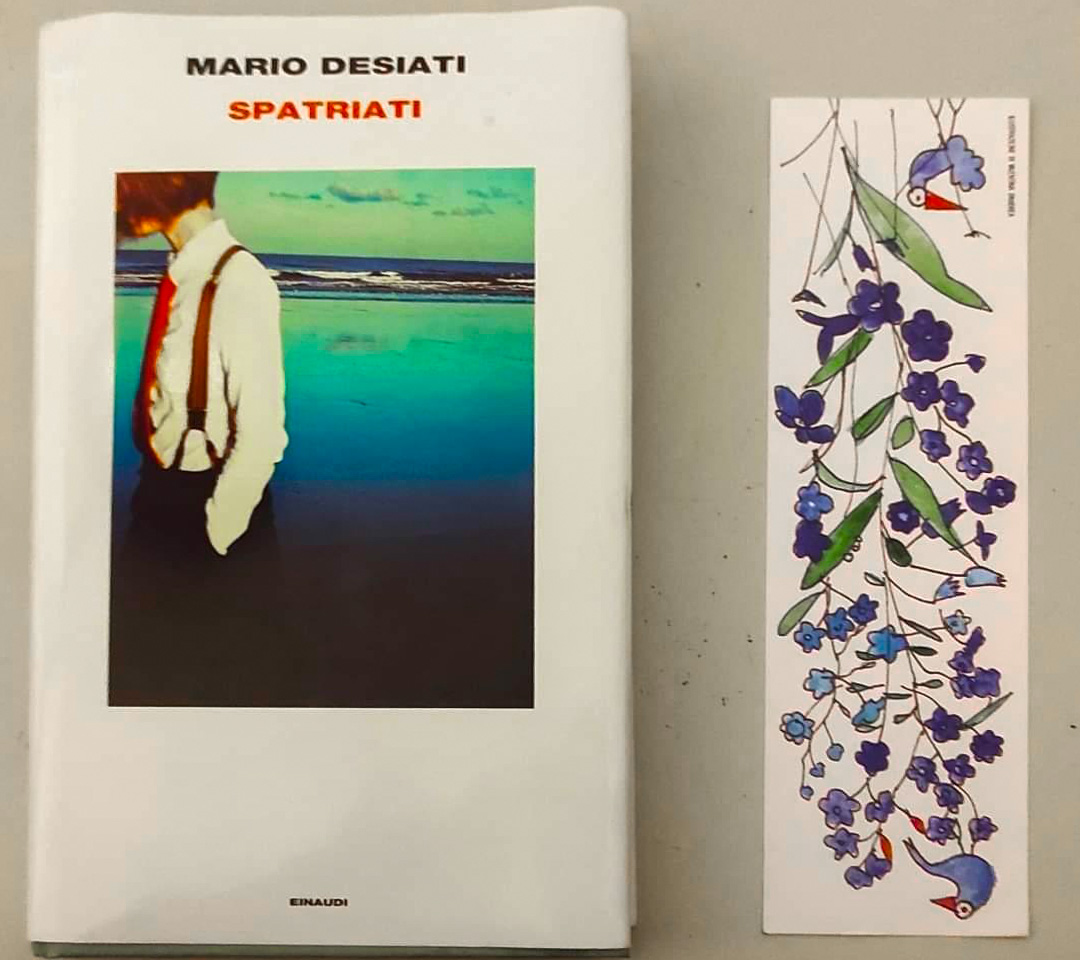“Dove non mi hai portata”: Maria Grazia Calandrone

Dopo “Splendi come vita”, in cui l’autrice affrontava il controverso rapporto con la sua madre adottiva, in “Dove non mi hai portata”, la Calandrone riprende il tema materno, questa volta ripercorrendo con dovizia di particolari, la struggente storia di Lucia Galante, la sua madre biologica morta suicida nelle acque del Tevere dopo aver abbandonato la sua bambina all’ingresso di Villa Borghese.
Quando circa due anni fa, mi approcciai alla lettura di “Splendi come vita”, rimasi sin da subito molto colpita da quella che sembrava essere a tutti gli effetti un’ideale lunga lettera d’amore a Consolazione, la sua madre adottiva, pur se composta di pagine di diario, episodi narrati in prima persona, ricordi brucianti, ferite mai rimarginate. Immagini e parole, a volte appena sussurrate, che assurgono quasi a strumento di sopravvivenza per vedere meglio la realtà visibile, ma soprattutto quella invisibile. Questo romanzo per me è stato quasi come un’epifania, che mi ha permesso di guardare al rapporto con la mia mamma adottiva, con altri occhi e da un’altra prospettiva, quella di una giovane donna a sua volta adulta, perché come afferma la stessa Maria Grazia, “quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria madre, la si può finalmente “vedere” come essere separato, autonomo e, perciò, tanto più amabile”.
Sarebbe dunque inutile negare il notevole carico emotivo che ha preceduto e poi accompagnato la lettura di questo secondo libro, candidato al Premio Strega 2023. Chi ha alle spalle una storia simile alla mia può comprendere quanto a volte sia difficile imparare a convivere con la paura del rifiuto, con il sospetto atroce di essere stati abbandonati senza neanche un perché. Questo dolore ancestrale, viscerale, assai difficile da ignorare, diventa quasi il tuo indesiderato compagno di vita. Si cerca di sopravvivere e con il tempo si impara a fatica “l’arte dell’equilibrista” per provare a non soccombere, perché la vita va avanti e nonostante tutto non ti ha voltato le spalle: eppure quel dispiacere che ti accompagna dalla notte dei tempi, è sempre lì in agguato, come un mostro latente pronto a colpire subdolamente ogni volta che non ti senti “abbastanza” ed in ognuna di queste volte “rialzarsi” è quasi come imparare nuovamente a camminare, ricominciare tutto daccapo.
Probabilmente è anche per tutti quelli come me e come lei, che questa volta, Maria Grazia Calandone, si cimenta nell’ardua impresa di esplorare “un metodo per chi ha perduto la sua origine”, ricostruendo, quasi alla stregua di una detective, la vicenda umana della sua madre biologica, partendo dalla sua infanzia sino ad arrivare all’epilogo drammatico della sua morte. Lucia Galante nasce nel 1936 da un’umile famiglia di contadini in un piccolo paesino del Molise, Palata. La giovane ragazza dalla vispa personalità, ben presto viene costretta dalla sua famiglia a sposare il perdigiorno e buffone del paese, Luigi detto “centolire”, che ha il solo merito di possedere un piccolo terreno confinante con quello dei genitori di Lucia, e tanto basta perché questa giovanissima donna, già sottratta agli studi, venga strappata anche dal suo amore giovanile, il dolce Tonino, pretendente povero, senza terreni e quindi non alla sua altezza.
Lucia viene dunque destinata ad una vita infernale con un marito impotente e violento, la sua famiglia che le volta le spalle, il paese che pur provando compassione per tutte le angherie che è costretta a subire, preferisce rimanere in silenzio , trincerandosi dietro un moralismo omertoso e colpevolizzante, dopotutto quella in cui vive, è la realtà arretrata ed arcaica di un piccolo paesino del sud Italia a cavallo dei primi anni sessanta. Poi un giorno a Palata arriva Giuseppe, ingaggiato per la costruzione di un acquedotto in Molise, e nonostante sia un uomo di mezza età, sposato con cinque figli, si innamora di Lucia e in barba a a tutte le convenzioni sociali e al perbenismo imperante dell’epoca, decide di rimanere con lei. Agli occhi della ragazza, Giuseppe è il suo salvatore, l’uomo che la porta via da quella sua dura realtà e con il quale intravede finalmente il miraggio di una vita non infernale. Lucia, forte del suo nuovo amore seppur incosciente per i diktat di quei tempi, decide quindi di rivendicare la sua libertà di autodeterminazione, e forse per questo motivo, la possiamo quasi considerare una “femminista inconsapevole”, sebbene lei non sia spinta dal perseguimento di un ideale, ma da un vero e proprio spirito di sopravvivenza. Questo stato di necessità spingerà poi i due amanti, lei incinta di sette mesi, lui reo di essere un marito fedifrago e con una denuncia per adulterio pendente sulle loro teste a lasciare l’arcaico Molise per Milano, simbolo per eccellenza del “miracolo italiano”, considerata la città del futuro che non nega a nessuno (o quasi) una possibilità di riscatto economico e non solo. In realtà la stessa metropoli di quegli anni, è anche ricca di contraddizioni, e a tal proposito la Calandrone non perde l’occasione di affrontare il tema della difficile condizione degli immigrati meridionali al nord, spesso relegati ai margini della città, nelle cosiddette “coree”, che l’autrice descrive come “discariche sociali ultraperiferiche, pullulanti di casette abusive e vagoni di treno adibiti a uso abitazione, o in quartieri di casermoni fabbricati in fretta” .
Di fatto è in questo contesto che il sogno di una nuova vita per Lucia e Giuseppe, malgrado tutto, stenta a decollare, i due sopraffatti dalle cose e dagli eventi, il lavoro in nero, il denaro che scarseggia, la bambina costretta a portare il cognome di un uomo che non ne è il padre e una vita da braccati, maturano la drammatica decisione di raggiungere la capitale e di affidare la piccola Maria Grazia “alla compassione di tutti” e i loro corpi alle acque del Tevere, non prima però di aver avuto la premura di spedire all’Unità, considerato il giornale “progressista” dell’epoca, una lettera in cui spiegano le motivazioni del loro gesto, in un ultimo atto di dignità che in verità ha tutta l’aria di essere una vera e propria denuncia sociale nei confronti di una società ancora fortemente classista, retrograda e reazionaria. Leggendo il triste epilogo di questa storia, si avverte quasi la sensazione di scorgere lo sguardo disperato e sconfitto di questa giovane mamma, che per garantire una vita decorosa a sua figlia è costretta a rinunciare alla propria. Quella della Calandrone è un’indagine minuziosa che mette insieme oggetti e voci, luoghi e persone, documenti e lettere, referti e timbri, senza trascurare alcunché, senza lasciare nulla al caso, ma soprattutto senza alcun tipo di pregiudizio.
Non sono sicura se un giorno riuscirò anch’io a trovare il mio “metodo matematico di sentimento e pensiero” per ricostruire la mia origine perduta, ma di sicuro confrontarmi per la seconda volta con Maria Grazia, mi ha regalato ancora una volta un’altra preziosa prospettiva dalla quale poter guardare la mia storia. Ad oggi c’è però una cosa che le invidio, la consapevolezza di essere stata con coraggio affidata alle cure di un’altra famiglia non senza un motivo, né per disamore ma per necessità e in questo specifico caso, quasi per costrizione. Forse in fondo, nonostante mi sia da sempre ripetuta che rivalutarsi come risultato di scelte precise, senza lasciarsi andare ad ogni tipo di fantasticheria o romanticheria, aiuta ad alleggerire il sentirsi in debito di riconoscenza e a ridare dignità e integrità alle persone che queste scelte le hanno compiute, che siano scelte di abbandono o di accoglienza, mi auguro che anch’io un giorno possa avere lo stesso tipo di consapevolezza, quello di non essere stata “vittima del disamore”.
“Esploro un metodo per chi ha perduto la sua origine, un sistema matematico di sentimento e pensiero, così intero da rianimare un corpo, caldo come la terra d’estate, e altrettanto coerente.”